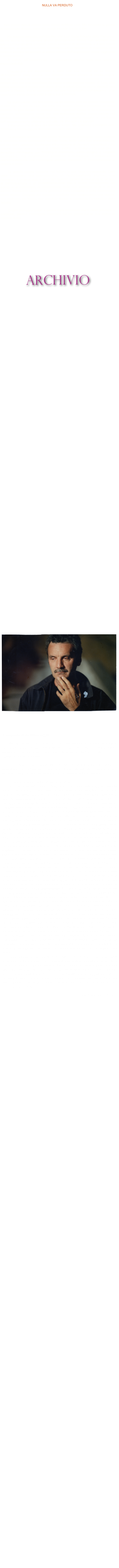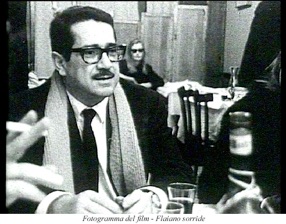NOTE APPUNTI SAGGI INTERVISTE
Lo spazio del cinema-documentario inizia là dove finisce il giornalismo. Lo dico senza nessuna intenzione polemica, semplicemente credo che siamo di fronte a sfere, a paradigmi di natura diversa.
Nè io credo si possa parlare, come si fa di solito, per connotare la natura del documentario, di <presa diretta sulla realtà>, <cinema del reale>, idealmente contrapposto al cinema della finzione: perchè <realtà> nessuno sa cos’è. A nessuno è dato di sapere a priori cos’é reale e cosa non lo è. Appurarlo è il compito di una vita, lo si scopre a brani, a volte, quando ne siamo capaci, quando ci viene concesso, di solito drammaticamente. E a volte veicola più realtà una favola, che qualsiasi altra forma del discorso. Nel senso comune invece si dice <realtà> intendendo ciò che ci sta di fronte, e che in fondo sarebbe semplice da cogliere, basta volerlo: basta portare in quel punto lì una camera per afferrare ciò che lì è reale, e registrare i fatti.
Ma la verità è che non esiste un accesso diretto al reale: in nessuna circostanza della vita noi possediamo gratuitamente questa chiave, perchè tutto, tutto è celato, tutto è sempre qualcos’altro. Il rapporto tra apparenza e sostanza è in continua metamorfosi e resta nascosto tra aculei e spine. Tra guardare e vedere c’è una distanza a volte incolmabile. Nulla é più misterioso di un fatto.
E a poco vale invocare il cosiddetto <sguardo critico>. Che si presenta come il punto di vista emancipato capace di affrancarci dalla rete degli inganni attraverso cui i vari poteri reggono i fili del mondo, mettendoci in condizione di cogliere ciò che è com’è, come oggettivamente è. Anche questo, quando non si tratta di una semplice maschera ideologica è un’ illusione, un miraggio, perchè in realtà noi vediamo gli altri solo attraverso noi stessi, non altrimenti. Ciascuno riesce a scorgere nell’altro ciò che gli è conforme, in positivo o in negativo. Il più delle volte, per paura, tendiamo a circondarci di statue fatte secondo le notre misure, e chiamiamo questo realtà.
Nino Bizzarri, estratto da Premessa alla Personale organizzata dal Doc Fest di Palazzo Venezia (2006)
Breviario personale
<E’ la meraviglia più che il dubbio la fonte della conoscenza (di ciò che è reale). Il dubbio è un atto mentale che dipende da altri elementi: prima noi vediamo, poi giudichiamo e ci formiamo una opinione e solamente dopo cominciamo a dubitare. Prima di poter dubitare dobbiamo giudicare e arrivare a credere nel nostro giudizio. Ma se per esaminare dobbiamo prima conoscere, se per dubitare di una credenza dobbiamo prima sostenerla, il dubbio non può essere l’origine della conoscenza. …
In realtà sotto il mare fluttuante delle nostre teorie e delle nostre spiegazioni giace l’abisso di uno stupore radicale. Lo stupore radicale possiede un raggio d’azione più vasto di ogni altro atto umano>
Abraham Heschel, L’uomo non è solo
<La carne non è che il vaso del sentimento. L’intelletto, facoltà secondaria, è stato dato all’uomo al solo scopo di chiarire l’importanza fondamentale del sentire. Solo il sentimento è realtà. Tu non sai amare e vorrestri pensare correttamente?>
Oscar Milosz, L’iniziazione amorosa
Il sentire è ciò a cui si concatenano tutte le cose (Eraclito Frammenti)
<Non nella Storia universale, come vaneggia la filosofia dei professori, c’è disegno e unità, ma nella vita del singolo> (Arthur Schopenhauer , Supplementi al Mondo)
<La Storia non è altro che una compilazione delle deposizioni fatte dagli assassini circa le loro vittime a se stessi> (Simone Weil)
<Immaginazione, questa superba facoltà nemica della ragione è la parte dominante dell’uomo>
(Pascal, Frammenti)
<Non sono i bisogni, ma le passioni che muovono gli umani> (Simone Weil)
<Ho imparato, scrivendo canzoni, che quando si è <intimisti>, è solo allora che si parla di temi universali> (Leonard Cohen, Intervista)
<Ciò che può essere mostrato non può essere detto> (Ludwig Wittgenstein, Tractatus logicus-philosophicus)
Fino a che non si rispecchia in un racconto la vita procede confusa e dispersa. <Solo la narrazione rivela il significato di ciò che altrimenti rimarrebbe una sequenza intollerabile di eventi. Rivela il significato senza commettere l’errore di definirlo.> (Hanna Arendt)
<Idolatra è tutta la letteratura pedagogica che intende istruire e ammaestrare> (Simone Weil)
<Io credo che la classicità sia consustanziale al cinema, mentre l’astrattismo è vietato, perchè a differenza della pittura il cinema è essenzialmente arte legata alla realtà. Io ero contro tutta la tendenza linguistica degli anni 70. Per me la vera modernità va ricercata in un certo modo di ritratte gli essere umani nel mondo, la relazione dell’uomo con le cose.> (Eric Rohmer, Scritti)
<Io sono sempre stato contro la tendenza strutturalista, linguistica, degli anni 60-70. Per me l’importante nel cinema è l’ontologia, non il linguaggio. Ontologicamente il cinema dice qualcosa che le altre arti non dicono, mentre il suo linguaggio alla fine assomiglia a quello delle altre. Se lo si studia vi si trova in maniera più rozza e meno complessa la retorica che si trova nelle altre arti. E dunque (per quella strada) non si arriva a nulla, se non a dire: il cinema è qualcosa che sa imitare le altre arti.
(Eric Rohmer, Scritti)
<Io odio la cinefilia, la cultura cinefila. Il cinema è l’arte che meno di tutte può nutrirsi di se stessa. Per le altre arti è sicuramente meno pericoloso.
(Eric Rohmer, Intervista)
<Occorre avere il coraggio ben chiaro della onestà: dietro questo trouver du nouveau ad ogni costo si nasconde un principio di dissoluzione >
(Carlo Emilio Gadda, I viaggi la morte)
Sulla questione della forma. Io credo che sia stata risolta seriamente, in profondità, una volta per tutte, da un architetto, Adolf Loos: <Lavoriamo meglio che possiamo senza soffermarci un solo istante a meditare sulla forma. La forma migliore è sempre già pronta.> (Adolf Loos, Parole nel vuoto)
Rossellini io l’ho conosciuto nel 75, grazie al suo aiuto Beppe Cino, cui chiesi di incontrarlo. Avevo un po’ più di vent’anni e mi trovai a fare l’assistente alla regia sul set di “Anno Uno”. Avevo l’incarico di controllare gli attori, la memoria, l’esattezza delle battute, in certi casi occorreva fare il suggeritore, appostato dietro una tenda o accucciato sotto la macchina da presa. Per il resto sono rimasto per tutto il tempo in ascolto, senza dire una parola. Era un po’ come quando da piccoli si va a lezione di catechismo; non si comprende nulla, semplicemente si assorbe qualcosa. Poi un giorno, inaspettatamente, a contatto con un’esperienza particolare, ciò che si è depositato sul fondo oscuro della coscienza risuona, e finalmente si capisce. Credo che ogni insegnamento che conta funzioni così.

Quanto a ROSSELLINI SOTTO IL VULCANO è stato girato nel ‘98, grazie alla complicità produttiva di Franco Porcarelli. Il progetto è nato un anno prima mentre ero a Stromboli con l’incarico di fare un piccolo documentario sugli emigrati dell’isola. E ricordo che a un certo punto mi sono trovato di fronte alla casetta rosa dove al tempo delle riprese abitava Ingrid Bergman. Era chiusa e disabitata. La scrutavo, cercavo di vedere l’interno, e la gente del luogo che si trovava a passare si fermava spontaneamente per spiegarmi. Mi descrivevano l’interno con esattezza, sapevano tutti dov’era la camera da letto, dove il soggiorno, e l’angolo del giardinetto incolto in cui Ingrid riceveva segretamente il regista a fine giornata. E parlavano della sua bellezza inarrivabile. Poi parlavano della lavorazione del film a cui tutti gli abitanti per un verso o per l’altro avevano partecipato, e si sentiva che per loro si trattava di un avvenimento epocale, narrato di padre in figlio. Ognuno raccontava con un tono diverso, ma molto partecipato, di un’impresa durata cinque mesi, da tramandare come gesta. E Ingrid non era soltanto la famosa attrice america, era una creatura dotata di un’aura benigna, venuta da lontano sull’isola a portare del bene, degna di essere ricordata per sempre . Tant’è vero che sul muro laterale della chiesa venne fissata dopo la sua partenza una lastra in ceramica, con sopra scritto: <Divina attrice, tu di Rossellini il pensiero ispirasti, legando il volto tuo a questa isola di fuoco, e ora Stromboli esulta, e qui tra noi immortale tu resti.> La scritta fu fatta togliere dopo anni da una vescovo, che giudicò eccessiva una preghiera per una donna dello spettacolo… Una trasfigurazione simile l’ho ritrovata solo lavorando qualche anno dopo ad un film su Eleonora Duse: ho visto la sua tomba nel cimitero di Asolo visitata costantemente non solo da aspiranti attori, americani tedeschi francesi, che studiano il suo metodo, quanto, ancor di più, da coppie di giovanissimi fidanzati, provenienti dalle valli e le città attorno, che prima di sposarsi passano a portare dei fiori. Non certo per il suo essere stata un’attrice, ma per qualcosa d’altro, che lo trascede. A Stromboli intanto le persone mi portavano volentieri a ritrovare i luoghi del film, uno ad uno, le case usate, gli esterni, la chiesa, la grotta marina dell’incontro tra Karin e il guardiano del faro, perfino le zone in cima al vulcano dove Ingrid si arrampica esausta alla fine del film. Era la prima volta, dopo cinquant’anni, che qualcuno tornava sull’isola per chiedere di quell’avvenimento, e c’era in tutti loro uno scrupolo: ci tenevano che nulla andasse perduto. (So che dopo di allora altri sono andati a girare e scrivere libri sul tema) Poi ho incontrato i principi siciliani Francesco Alliata e Quinto Di Napoli, che in origine dovevano essere i produttori del film. Ho chiesto loro di cercare quanto rimaneva di carte e fotografie, e credo di aver scoperto una cosa, che Rossellini non era mai stato di persona a Stromboli, l’aveva scoperta grazie ad un documentario notevole (Isola di cenere), girato proprio dai siciliani, insieme a Fosco Maraini e Renzo Avanzo, curiosissima, bella figura di barone, cugino di Roberto, assistente su qualche suo film senza firmare. Era stato Renzo Avanzo a chiedere a Rossellini di vedere il documentario, lo avevo spinto a scrivere il soggetto per un film con Anna Magnani ambientato sull’isola, e quando entrò in scena Ingrid fu lui, non Anna, a sentirsi tradito, al punto da fare fuoco e fiamme per allestire una sorta di contro-film girato su un’isola vicina a Stromboli, creando, senza volerlo, l’accadimento più spettacolare e seguito del dopoguerra. Anche tutto questo è narrato in ROSSELLINI SOTTO IL VULCANO.
Per quanto riguarda il mio rapporto personale con Roberto Rossellini, posso dire questo: c’è una cosa, tra le altre, di lui, che mi ha sempre molto colpito. Riguarda l’atteggiamento nei confronti del suo lavoro. Mai la benché minima ostentazione. Ciò è evidente anche all’interno del suo cinema, le sue sono immagini prive di ogni ostentazione, e questo spicca in un’epoca in cui siamo circondati da immagini che prima di tutto si compiacciono di sé, si pavoneggiano. Ma egli era così anche fuori, aveva una sorta di rigetto istintivo, una vera e propria ripugnanza per il vanto, per ogni srta di compiacimento riguardo alla figura dell’autore, dell’artista, dell’arte. La stessa attitudine che ho riscontrato ad esempio in Mario Luzi, che ho conosciuto più tardi. E si riscontrava identica in Montale, in Adalberto Libera, in Tomasi di Lampedusa, per dire di alcuni grandi su cui ho avuto modo di lavorare: la stessa innata ritrosia. Non si tratta di una questione di stile, è questione di sostanza, corrisponde al senso metafisico della misura e della decenza, dietro cui sempre si nasconde la grandezza. Per me è stata una lezione di vita, la scoperta di un metro di misura universale: dove c’è ostentazione non c’è grandezza.
Scritto in occasione della presentazione del film al Louvre, Parigi
-filtered.jpg)
Com’è costruito DOV’E’ LA FENICE
INTERVISTA PER UNA TESI DI LAUREA, UNIVERSITÀ ROMA TRE. (2007) Estratti
Che cosa l’ ha spinta a fare un documentario sull’incendio della Fenice?
Un giorno, dopo la fine del processo per l’incendio, che si era chiuso con la condanna di due responsabili, stavo parlando con Franco Porcarelli, il produttore, ad è stato lui che mi lanciò l’idea di fare qualcosa. Io avevo visto chissà quante volte le immagini del fuoco passate nei telegiornali, sempre le stesse, cinque minuti ripetuti infinite volte, e mi ero chiesto che cos’era successo in realtà, dato che l’incendio era durato una notte intera. Il fatto che non s’era trattato di un incidente, ma erano stati scoperti i colpevoli (due elettricisti in ritardo sui lavori), per quanto la cosa fosse agghiacciante non modificava la domanda: cos’era accaduto durante quella notte, che cosa aveva significato la riduzione in cenere di un luogo come quello, così raro, prezioso, carico di storia, e di vita realizzata? Di tutto questo nulla era passato attraverso l’informazione, perchè l’informazione ha bisogno di essere rapida, deve accumulare il massimo possibile di notizie sul momento e passare oltre.
Dove è stato reperito il materiale per il documentario? In quali archivi?
In nessun archivio, in realtà. Era materiale raccolto in una stanza nella sede Rai di Venezia. Comprendeva le riprese fatte da tutti quelli che erano accorsi alla Fenice quella notte: operatori della Rai e altri arrivati spontaneamente. Quando andai a curiosare mi accorsi che c’era una quantità incredibile di cassette accumulate, di materiale grezzo. Ho cominciato a visionarlo è ho sentito il batticuore.
Ci può descrivere in grandi linee quali sono stati i passaggi fondamentali per la costruzione del documentario?
Prima di scoprire il materiale avevo in mente un progetto di massima che prevedeva il ricorso al ricordo di varie persone, da quelle che avevano assistito all’incendio, agli abitanti delle case vicine, i musicisti che avevano passato una vita all’interno del teatro, i vigili del fuoco, ecc…
Ma di fronte alle immagini ho subito pensato che il film da fare era un altro. Oddio, il girato era spesso girato male, ripetitivo, inerte, ma c’era anche del materiale notevole. Allora ho pensato che era il caso di accettare una sfida: fare il film esclusivamente con immagini e suoni, senza parole, né dei cosiddetti testimoni, né di un eventuale testo fuori campo. Tutto il racconto doveva prendere corpo attraverso la giustapposizione dei vari frammenti esistenti senza una sola parola di supporto.
Il lavoro determinante quindi è stato quello della scelta, la selezione delle immagini da montare. Ho portato tutto in una sala di montaggio a Roma e ho passato parecchio tempo a studiare il girato, almeno un paio di mesi, per scegliere in base a un criterio: bisognava costruire un tessuto visivo omogeneo, in modo che non si avvertisse che le inquadrature erano frutto di mani diverse, si doveva creare l’impressione che fossero tutte filmate dalla stessa mano. Altrimenti sarebbe passata la sensazione di un cumulo di materiali rimediati, e questo avrebbe impedito di costruire un racconto. Perciò mi sono messo a visionare, a volte quasi fotogramma per fotogramma, tutte le inquadrature utili. In montaggio oggi, con il digitale alcune cose si possono correggere, per esempio il croma, la qualità cromatica, ma altre non si possono correggere. Se l’inquadratura non è equilibrata, se il punto di vista è troppo basso, troppo alto, troppo ravvicinato, se non è centrato, non si può correggere. E per il film, per costruire l’impressione, anzi, la concreta sensazione, dell’incombere del fuoco, era necessaria una gamma completa, intera di inquadrature.
È d’accordo nel definire “Dov’è la fenice” un documentario narrativo di montaggio?
Quando si dice film di montaggio, nel gergo comune, si intende quel genere di documentari storici che è la messa in ordine cronologico di cose scovate negli archivi, la cui funzione è quella di illustrare accadimenti e personaggi storici. Se questo è il documentario di montaggio, DOV’E’ LA FENICE è un’altra cosa. Non è fatto per rendere conto di un periodo storico, non è fatto per illustrare la ratio di una serie di accadimenti, il suo intento non è far passare dati o interpretazioni, non è nulla di tutto questo. Il film è montato secondo un criterio di costruzione che tende non a informare, o ad insegnare, ma a far sentire ciò che accade.
Per dire qualcosa di più preciso, posso segnalare che DOV’E’ LA FENICE è una sorta di requiem diviso in quattro capitoli, che non sono indicati, ma regolano la scansione e le durate del racconto. I capitoli sono: La Gloria, L’Agonia, Il Lamento e Il Presagio. Nella prima parte, lo spettatore percepisce com’era il teatro prima del rogo, un luogo carico di vita realizzata, ossia di gloria. Poi c’è il capitolo dell’agonia: l’incendio e le numerose prove per domarlo, il tentativo umano di essere più forte della morte, ma la morte prevale. Poi c’è la fase del lamento: finita la notte, il giorno dopo una macchina a mano descrive cosa resta a fuoco spento. E’ qualcosa che sgomenta, addolora. E’ il momento del lutto. E infine, il presagio. Dato dai primi segni della rinascita: la morte è prevalsa, ma non è detto che significhi la sua vittoria, perché esiste anche la facoltà di ritrovare qualcosa che abbiamo perduto.
Ecco il senso della costruzione — noi non sentiremmo dolore se prima non avessimo avuto modo di amare il teatro, e non sentiremmo il senso di liberazione finale se prima non avessimo sentito l’angoscia della perdita.
II° INTERVISTA PER UNA TESI DI LAUREA, UNIVERSITA DI PARMA, (2007) Estratti
In effetti, quando all’epoca ho sentito la notizia dell’incendio in televisione, e comunque non ci ero mai stato e non avevo mai visto dal vivo la Fenice, non era per me una notizia sconvolgente, ma vedendo il suo documentario mi è stata trasmessa l’emozione di quell’evento. Lei ha parlato molto del fuoco, ma nel suo documentario è molto presente e forte il rapporto tra fuoco e acqua. E’ quasi un colmo che una città circondata e fondata sull’acqua, vada a fuoco…
E’ un rapporto quello tra il fuoco e l’acqua dove l’acqua soccombe, perché sembra non avere nessun potere, nessuna capacità, nessuna possibilità di arginare la potenza assoluta, misteriosa e tremenda del fuoco, non ce la fa. C’è anche il momento in cui compare l’elicottero, che sembra un elicottero cinematografico, che arriva da un film americano, invece è un elicottero che i vigili del fuoco avevano a disposizione ed è l’ultimo tentativo per cercare di salvare il salvabile, ma non ha nessun effetto, l’acqua che riversa si disperde totalmente, come una polvere, anche perché c’era del vento. Il fuoco è al massimo della sua potenza distruttiva quando ad aiutarlo c’è il vento, che sembra voler infierire, sembra star lì proprio per combattere a fianco del fuoco e quindi il vento e il fuoco contro l’acqua, la rendevano assolutamente impotente. C’è qualcosa di patetico quando entra in scena l’elicottero, che butta giù quelle secchiate d’acqua che si polverizzano nell’aria. E’ la scena di un duello impari, e il protagonista soccombe senza avere colpa. Montando il film, mi accorgevo che il racconto fuoriusciva da un registro realistico, al punto che alla fine, quando c’è quel campo lungo, anzi lunghissimo, che chiude la sequenza del fuoco, prima che si passi al giorno dopo, sembra per un attimo di vedere da lontano l’incendio delle mura di Troia. E’ qualcosa che sta sullo sfondo, e io avevo la sensazione che dopo un quarto d’ora , dopo 10- 12 minuti in cui vedi il fuoco divorare il corpo dell’edificio, tu non sei più di fronte a qualcosa che sai essere accaduto una certa notte a Venezia, ma di fronte ad una cosa, terribile, che accade sempre.
C’è un’altra sequenza che mi ha molto interessato: quella in cui la città si svela lentamente dietro il passaggio di una nave. C’è quasi l’illusione che Venezia fuoriesca dalla pancia di questa nave, e in effetti Venezia è nata dall’acqua. Ma ci ho visto anche il rapporto con la modernità, il progresso. Qual è secondo Lei il rapporto di Venezia con la modernità? Una modernità che può distruggere o salvare Venezia?
Né l’uno e nell’altro. Il progresso è qualcosa di fatale, da una parte è necessario, dall’altra è nocivo, però è un processo ormai intrinseco allo stato del mondo, non è più immaginabile un arresto, un blocco. Se non per via di una catastrofe. Per fortuna è caduto il mito del progresso che porterebbe solo beneficio, quello era un abbaglio. Distrugge nel corso del suo rivelarsi, nel corso del suo procedere, c’è un lato distruttivo. Venezia si è giovata, si giova e sicuramente si gioverà di alcune cose che hanno a che fare con la modernità, dall’altra però ha anche un destino di grande fragilità.
Mi ha colpito molto l’immagine dell’uomo seduto all’interno del teatro distrutto che ad un certo punto si alza e se ne và. E’ l’ultimo spettatore della Fenice?
Su questo sei libero di pensare quello che preferisci… non vorrei commentarla. A me ha colpito perché l’uomo è solo, vestito di nero, indossa un cappotto-mantello e attraversa le rovine con un’aria indifferente, la scena è terribile, ha ispezionato le rovine ma questo non gli fa nessun effetto. A me stupisce, e non mi sono neanche chiesto che cosa passa da quella figura, ho trovato che doveva esserci.
Ma tornerei un attimo sull’immagine della nave, perché quella invece è voluta, quella è una delle parti girate da me. A quel punto del film serviva un’idea per uscire dal capitolo del lutto. Perché dopo il fuoco c’è la contemplazione del teatro distrutto, un’esplorazione dolorosa, quella è la parte dove viene da piangere. La parte precedente, in cui senti l’agonia, comunica una sorta di angoscia, paura, terrore..
Quasi incredulità…
Infatti, sei attonito. Poi c’è il pianto, per la morte che ha vinto sulla vita. E’ il lutto, il senso del lutto. Infine c’era il bisogno di uscire dal clima del lutto, nel modo più radicale possibile, definitivo, non doveva restare nulla nell’aria, qualcosa doveva passare sullo schermo e portar via totalmente il senso di morte…
E la nave se lo porta via…
Sì, la nave è una specie di grande figura, non è soltanto una nave, ma qualcosa di enorme, la figura di un gigante che occupa l’immagine intera, e che scivolando via purifica l’aria liberando Venezia: tornano i colori, l’azzurro del cielo, e la luce. Mi ero domandato come fare e mi sono ricordato di aver assistito più volte da San Giorgio Maggiore al passaggio delle navi da crociera che arrivano e partono da Venezia quasi tutti i giorni. La prima volta ero rimasto shockato, hai difficoltà a mettere in relazione la grandezza smisurata di quelle macchine semoventi sull’acqua con la dimensione minuta, quasi tremante, di Venezia. Quindi mi sono posizionato sul bordo dell’isola di San Giorgio in modo da avere dall’altra parte lo skyline più famoso di Venezia, e la nave abbastanza vicina da occupare per qualche attimo lo schermo intero.
È quasi un sipario…
Esattamente. Un sipario che chiude una parte della rappresentazione e ne apre un altro. Subito dopo c’è il capitolo del Presagio, in cui si annuncia qualcosa, ossia l’inizio della rinascita. Nel caso della Fenice questa non è semplicemente una buona cosa, la rinascita è nella sua natura.
Il destino nel nome…
Accadono cose difficili da spiegare, che però sono evidenti, hanno una loro evidenza: il teatro porta quel nome, era già successo nel ’36, viene distrutto dal fuoco, rinasce, nello stesso luogo, viene distrutto nuovamente dal fuoco, rinasce nello stesso luogo… Quel nome sancisce la sua vita particolare, il teatro rispetta la promessa contenuta nel nome, la necessità di un morire che non è definitivo.
E’ il segreto dell’eternità…
E’ qualcosa che sta all’origine della nostra civiltà.
Il finale del documentario è aperto. Gli uccelli sono ritornati a costruire i loro nidi sulle gru del cantiere, e i veneziani cominciano a ricostruire il loro “nido” che è il teatro. Tuttavia Lei non mostra il teatro ricostruito: è stata una scelta voluta?
Assolutamente, in fondo cosa importava? Ai fini del racconto importava far vedere il teatro completamente ricostruito? No, era sufficiente dire: il teatro rinasce, il teatro non è morto per sempre. Quell’incendio che sembrava avere un potere totale, in realtà (non è un processo immediato, richiede del tempo, ma non ha importanza, quello che conta è che alcune cose accadano) viene sconfitto, c’è una vitalità intrinseca nell’uccello fenice che non può essere annientata dal fuoco. Anzi il fuoco probabilmente aveva spazzato via una struttura, un involucro, che aveva chiuso il suo ciclo, non in quanto Teatro La Fenice, ma in quanto forma attuale del teatro la Fenice. Questo è detto nel film dalla sequenza della lettera che racconta degli uccelli. Una cosa che mi ha colpito quando me l’hanno raccontata: gli uccelli che abitavano su tetto del teatro e vi avevano fatto il nido, non erano andati via, sono rimasti sul luogo, hanno aspettato che il teatro risorgesse. Quando sono arrivate le gru per cominciare la ricostruzione, infatti, hanno fatto il nido sulle gru, sicuri che il loro posto sarebbe tornato a essere quello che era. E’ notevole no? Un elemento naturale, ossia un uccello, non ha mai preso in considerazione l’idea che il teatro fosse sparito, ma solo che sarebbe stato assente per un po’ di tempo, bastava aspettare. Questo è raccontato nel film attraverso una piccola finzione, la lettera, che è del tutto inventata. Era il solo modo per far passare questa cosa magica degli uccelli, e ho pensato ad un ipotetico viaggiatore che arriva a Venezia, gli capita di abitare in un albergo vicino alla Fenice e il portiere gli fa notare il nido in cima alla gru.